pubblicato ad aprile 2025
prossimamente 2025
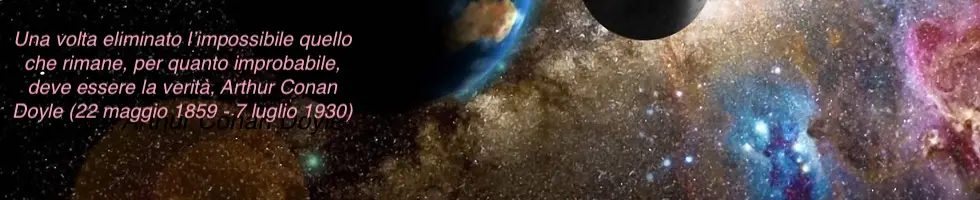
medicina
I 5 sensi

Dagli occhi, orecchie, bocca, naso e pelle entrano le informazioni più importanti, che vengono trasmesse al nostro cervello e ci fanno capire cosa succede intorno a noi. Ad ognuno di questi organi corrisponde uno dei cinque sensi e gli chiamiamo organi di senso.
- Agli occhi corrisponde la vista;
- All’orecchio corrisponde l’udito;
- Alla bocca corrisponde il gusto;
- Al naso corrisponde l’olfatto;
- Alla pelle corrisponde il tatto.
Abbiamo sempre pensato che ne esistono solo questi cinque, ma secondo i neurologi, oltre ai cinque sensi ne esistono altri quattro (sensi intercettivi):
- Termocezione: il senso del calore (o della sua mancanza);
- Nocicezione: percezione del dolore attraverso recettori della pelle (cutanei), delle articolazioni e delle ossa (recettori somatici) e degli organi corporei (recettori viscerali);
- Propriocezione: ossia il senso del movimento e la consapevolezza del proprio corpo, di dove sono le sue parti anche senza toccarle o vederle. Usiamo questo senso spesso senza rendercene conto, ad esempio quando saliamo i gradini di una scala senza guardarli tutti. Le persone con scarsa propriocezione, in genere vengono ritenute goffe e scoordinate.
- Senso dell’equilibrio: determinato dalle cavità piene di liquido (sistema vestibolare) del nostro orecchio, che forniscono al cervello le informazioni riguardo alla posizione della testa e del corpo nello spazio circostante.
La vista
L’occhio o il bulbo oculare, è l’organo di senso esterno dell’apparato visivo, che ha il compito di ricavare informazioni sull’ambiente circostante attraverso la luce.
L’occhio umano (e degli organismi superiori) raccoglie la luce che gli proviene dall’ambiente, ne regola l’intensità attraverso un diagramma (l’iride), la focalizza attraverso un sistema regolabile di lenti per formarne un’immagine sulla retina e trasforma quest’immagine in una serie di segnali elettrici che attraverso il nervo ottico vengono inviati al cervello per l’elaborazione e l’interpretazione.
L'udito
L’udito è il senso di percezione dei suoni che provengono dall’esterno e che vengono trasferiti al cervello, alla corteccia temporale, ossia quella zona cerebrale in grando di decodificarli. L’udito è forse il senso umano più complesso: il primo a svilupparsi nel feto al contatto con il mondo esterno.
Questo senso rimane attivo, anche quando dormiamo. Inoltre, le orecchie non smettono mai di crescere. Questo accade a causa della cartilagine e del tessuto molle delle orecchie, che continuano a svilupparsi e allungarsi con l’età.
Noi sentiamo la nostra voce, anche, attraverso le vibrazioni ossee del cranio, che amplificano le basse frequenze, per questo motivo il suono della nostra voce è diverso da come lo percepiscono le altre persone.
Il gusto
Il gusto è il senso di percezione dei sapori di ciò che mangiamo e beviamo. Attraveso ricettori sensoriali posti sulla lingua, palato faringe e laringe, siamo in grado di distinguere amaro, dolce, salato e acido.
In seguito ad uno studio dell’Università di Oxford, si è dimostrato che è molto importante l’ambiente in cui viene degustato il cibo o la bevanda. In questo caso lo studio riguardava il whisky, che “cambiava” sapore a seconda dell’ambiente in cui veniva degustato.
Ad esempio, degustato in una stanza con un tapetto erboso e odore di erba appena tagliata, veniva percepita una fragranza ed un sapore erboso, mentre in una stanza dove era difusa una fragranza dolce veniva percepito un sapore dolciastro.

Il Portale delle curiosità di Cristina G.H.
e-mail: [email protected]
Sito: http://ilportaledellecuriosità.com/
L'olfatto
L’olfatto è il senso deputato alla percezione degli stimoli odorosi. I chemiocettori sono particolari cellule in grado di reagire alle caratteristiche chimiche delle sostanze odorose situate in una particolare area della mucosa nasale, la mucosa olfattiva. Questo senso è connesso in maniera funzionale con il gusto, come si può dimostrare quando un raffreddore congestiona le vie aeree, compromettendo la funzione olfattiva e facendo in modo che i cibi abbiano pressoché tutti lo stesso sapore.
Benché si reputi l’olfatto umano capace di discriminare circa 10.000 odori differenti, spesso questo senso è considerato il meno sviluppato nella nostra specie ed effettivamente molti animali riescono a superarci con le loro capacità olfattive. A moltissimi organismi viventi, l’olfatto consente, infatti, di raccogliere informazioni vitali e immediate sull’ambiente in cui si trovano e sul cibo disponibile, riconoscere potenziali partner, fiutare possibili pericoli ed eventuali nemici, cosi come percepire cambiamenti di situazioni e opportunità.
Nell’essere umano la capacità di distinguere gli odoranti tende a diminuire significativamente con l’invecchiamento (negli adulti over 70 è dimezzata rispetto all’adolescente) e con alcune patologie come disturbi alimentari, psicologici, neurologici e talvolta il diabete.
Inoltre, uno studio di Bendas, Croy e Hummel, recentemente pubblicato su Archives of Sexual Behavior, ha mostrato come un’alta sensibilità agli odori negli adulti, sia fortemente legata alla percezione di un maggiore piacere nelle attività sessuali, supportando l’ipotesi per la quale l’olfatto è in grado di arricchire e miglirare l’esperienza sessuale.
Il tatto
Il tatto (o sensibilità tattile) è il senso che rende l’uomo e gli animali capaci di rilevare, con una straordinaria precisione, la presenza di stimoli dovuti al contatto della superficie cutanea con oggetti esterni. Questo senso non ha una sede particolare e i suoi sensori sono distribuiti su tutto il corpo, non solo all’esterno, sulla pelle, ma anche in ogni tendine, muscolo e organo.
Il tatto è un senso complesso, diffuso su un’ampia superficie corporea. Ogni centimetro quadrato di pelle possiede circa 130 ricettori tattili, suddivisi in 5 tipi, che danno le seguenti sensazioni: freddo, caldo, tatto, variazione di pressione e dolore.
Senza il tatto la scrittura Braille, che da due secoli permette anche ai non vedenti di leggere, non ci sarebbe. Il senso del tatto è il primo a svilupparsi nell’essere umano. Il feto risponde a stimoli tattili già dalla settima settimana di gestazione.
Psicologi dell’Università della Virginia (USA) hanno osservato, per esempio, che se il partner ci accarezza quando siamo esposti a uno stimolo fastidioso, come un rumore forte, lo stress e l’attivazione di aree cerebrali connesse al senso della minaccia, diminuiscono. Quando veniamo toccati con gentilezza si riduccono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo (l’ormone dello stress), e si produce ossitocina, un ormone che tranquilizza facendoci sentire in pace col mondo.
Curiosità nella medicina
Sapevi che?
- La vista può consumare fino al 65% della potenza del cervello, più di qualunque muscolo o organo del nostro corpo. L’occhio del “Homo Sapiens” è un rilevatore molto sensibile, in condizioni di tenebra assoluta può riuscire a rilevare una quantità di energia luminosa nello spettro visibile umano equivalente a soli 5 fotoni.
- L’occhio è il muscolo più veloce del corpo umano, può vedere 500 sfumature di grigio ed è impossibile starnutire con gli occhi aperti.
- I rumori che superano i 200 decibel di suono possono uciderti.
- Mangiando banane, patate, fagioli, semi di girasole e frutta secca, consumate cibo radioattivo. Questi alimenti infatti, sono molto ricchi di potassio e lo 0,0117% degli atomi di potassio sono radioattivi.
- I raccoglitori di ananas hanno la tendenza a perdere le impronte digitali delle dita. All’interno di varie parti dell’ananas, in particolare su quelle esterne, c’è un’enzima che si chiama bromelina, che tenuta a contatto con la mano per molto tempo, evita la ricrescita delle proteine della pelle che rigenerano anche le impronte. Per fermare questo processo è sufficiente smettere di raccogliere ananas per 1 o 2 settimane.
- Nel 1929, Alexander Fleming pubblica la scoperta della Penicillina, nel British Journal of Experimental Pathology, dando origine all’era antibiotica.
- La cartella clinica fu inventata da Ippocrate, cosi come è ancora oggi in uso ed anche i concetti di “diagnosi e prognosi” furono adottati da lui per la prima volta per indicare la scoperta e il presunto andamento della malattia. Aveva la stima dei potenti e dei grandi intellettuali dell’epoca: Aristotele, Platone, Democrito lo consideravano un genio ed un medico scrupoloso.
Medioevo
- Come ha descritto lo scienziato Steven Pinker: “La vita nel Medioevo è pericolosa, umana e breve“. Il 50% dei bambini moriva prima dei cinque anni per malattie infettive, il numero di uomini sconfitti in guerra era elevatissimo e l’igiene personale scarsissima, in qualsiasi ceto sociale. Inoltre l’acqua era spesso raccolta da fiumi inquinati da liquami o rifiuti. Quindi il medioevo non era una bella epoca per viverci.
- Nel medioevo, l’altezza media era molto più bassa di quella odierna. L’altezza media di un uomo adulto si aggirava attorno ad 1 metro e 50 cm per gli uomini ed 1 metro e 40 per le donne. Questo fattore dipendeva dall’alimentazione a base di cereali. I cacciatori ad esempio erano molto più alti.
"Teoria degli umori" di Ippocrate
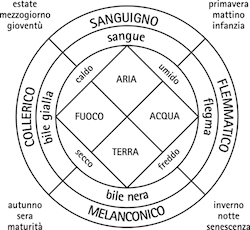
Tra le principali teorie promulgate da Ippocrate troviamo anche la cosiddetta Teoria degli umori . Il padre della medicina riteneva che le malattie si originassero da uno squilibrio dei quattro umori del corpo umano che, combinandosi in differenti maniere, avrebbero condotto alla salute oppure alla malattia. Tali umori venivano associati ai quattro elementi:
- L’acqua, umida e fredda, corrisponderebbe alla flemma (o flegma), la cui sede è nella testa.
- La terra, a causa del suo particolare colore, corrisponderebbe alla bile nera, la cui sede è nella milza.
- Il fuoco, caldo e secco, corrisponderebbe alla bile gialla (detta anche collera) la cui sede è nel fegato.
- L’aria, che è dappertutto, corrisponderebbe al sangue, la cui sede è il cuore.
Anche le stagioni iniziarono a essere percepite secondo questa suddivisione: la stagione del sangue e dell’aria corrispondeva alla primavera, mentre l’estate era quella del fuoco e della bile, l’autunno era quella della terra e l’inverno era quella dell’acqua e del cervello.

